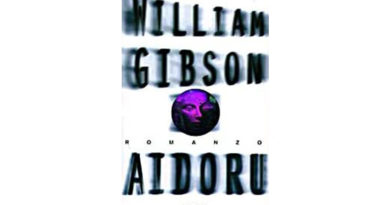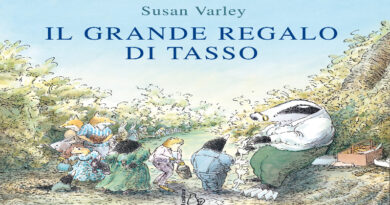Il dono e l’accoglienza del diverso
di Mistral
È tempo di Oscar negli USA, ma è anche un momento assai atteso per gli appassionati di cinema per riflettere sui contenuti dei film vincitori. Non mi assurgo certo a esperto cinefilo, ma non disdegno di tanto in tanto insieme a mio figlio (lui sì esperto) una lettura più profonda dei film che negli anni hanno lasciato un segno nella mia vita. Il pranzo di Babette è uno di questi. Tratto da un racconto di Karen Blixen, il film del 1987 è risultato vincitore nel 1988 del Premio Oscar come miglior film straniero; nello stesso anno ha ottenuto il Nastro d’Argento per la migliore attrice straniera, e anche la candidatura ai Golden Globes. Il cuore del film è concentrato nella seconda parte, quando emerge la figura di Babette, chef di un ristorante francese, che durante tutta la prima parte della narrazione è un personaggio che mantiene un basso profilo, quasi in totale anonimato in un paesino della costa danese dello Jutland, svolgendo umilmente l’attività di domestica al servizio di due sorelle nubili, figlie di un rigoroso pastore luterano. Le cose cambiano con la vincita di diecimila franchi a una lotteria francese. La cifra per chiunque sarebbe stata l’occasione per buttarsi dietro le spalle una vita piena di sacrifici e trovare un’occasione di riscatto proiettandosi verso un futuro di agi. Babette sceglie invece di usare tutto quel denaro per organizzare un raffinato pranzo alla comunità religiosa che in tutti quegli anni l’aveva accolta.
Il film è una narrazione eccellente di quale sia il valore del dono e di come la convivialità intorno a una tavola possa renderlo ancora più regale. Per quanto sia superfluo, la storia umana è imprescindibile da quella del cibo; tutti gli esseri viventi si nutrono, ma il cibo è solo per l’essere umano un fatto culturale nel momento in cui lo produce, quando lo prepara e anche quando lo consuma. Ne Il pranzo di Babette la trasformazione del cibo è preceduta dal dono. Babette deve insistere molto per convincere le due padrone di casa a farle cucinare alla francese un pranzo in occasione del compleanno del decano della comunità. A nessuno può essere tolta la possibilità di donare all’altro, anche a chi come Babette ha vissuto in quella casa straniera come umile serva. Mentre Babette cerca di strappare il consenso delle due donne, già si prefigura nella sua mente la magnifica tavola e le succulente pietanze che sarebbero state la materializzazione di quel dono.
In un bel testo di meditazione del Monastero di Bose, Rubem A. Alves ebbe modo di scrivere che il cuoco «mangia parole prima ancora d’aver svolto il proprio lavoro. Il fuoco brilla sempre e le pentole bollono in continuazione nella sua immaginazione. I suoi occhi vedono i colori invisibili, il suo naso freme per profumi inesistenti, la sua bocca ha l’acquolina per gusti immaginari. Il pasto che non è ancora preparato è già padrone del suo corpo. La sua fantasia è una cucina e una festa. Vive nel futuro, è un essere escatologico». È questa preventiva elaborazione mentale che eleva il cibo a espressione culturale. Del resto, se proviamo a riflettere, è anche quello che facciamo quando elaboriamo pensieri: dentro di noi operiamo un atto di trasformazione, non molto diverso da quello del cucinare, in quanto elaboriamo le idee partendo dalla loro iniziale condizione di “materia prima” o “semilavorato”. Babette donando un pranzo alla comunità, ha offerto loro l’opportunità di assaporare il valore dell’empatia nelle relazioni interpersonali. Il cibo non deve essere ingordigia, ma neppure essere considerato così pericoloso se la pietanza è diversa dal solito piatto a base di stoccafisso o zuppa di birra e pane. Babette riuscendo a donare un pranzo così come lo ha pensato, ha modo di far comprendere che il suo stato di straniera, accolta dalla comunità e destinataria di attenzioni e sentimenti di compassione, senza quel dono, può paradossalmente far degenerare la relazione interpersonale che, carente di empatia, avrebbe messo a nudo, direbbe Stefano Zamagni, «l’umiliazione di essere considerati “oggetti” delle attenzioni altrui». Babette è dunque la metafora dello straniero, non diverso da quello citato dalle cronache dei nostri giorni verso il quale mostriamo repulsione, rigidità, timore, diffidenza. Dimentichiamo purtroppo che i termini “ospite” e “straniero” sono reciproci; del resto lo stesso termine latino hostis non solo veniva utilizzato per indicare lo straniero, ma anche l’ospite. La contrapposizione dei termini è solo in apparenza agli antipodi: Marino Niola, in un suo intervento all’interno di un saggio sul dono, ha scritto che siamo di fronte a «un dare che riceve o un ricevere che dà». Angela Frati e Stefania Iannizzotto dell’Accademia della Crusca vanno oltre e avallano il significato del termine hostis ricordando che lo stesso non può prescindere da un’altra «parola più conosciuta, hostia, che nel rituale romano indica propriamente ‘la vittima che serve a compensare l’ira degli dei’ (l’offerta è considerata quindi di un valore tale da bilanciare l’offesa), in contrapposizione con il termine meno specifico victima che indica un semplice ‘animale offerto in sacrificio’ (cioè senza nessun intento riparatorio)».
Quando Babette mette la comunità che l’ha accolta di fronte a cibi nuovi, diversi da quelli che abitualmente mangiava, rompe degli schemi. In quelle persone, attorno alla tavola, diffidenti verso la novità, accade quello che avviene anche ai nostri giorni quando ci dobbiamo confrontare con il “diverso” da noi. Ma è proprio in quel rapporto di attrazione-repulsione con l’altro che si gioca il vero valore del dono dell’accoglienza e, nello stesso tempo, la difficoltà di interagire con l’altro. Non potrebbe esprime meglio questo aspetto il già ricordato Marino Niola che è dell’idea che il rapporto con l’altro «è tuttavia indispensabile, ai singoli e alla collettività. Perché solo l’altro consente di disegnare il profilo della nostra identità sullo sfondo oscuro della sua differenza. Come un negativo fotografico, lo straniero, proprio perché è ciò che io non sono, mi rivela a me stesso per quello che sono». Per quanto possa sembrare paradossale, la differenza che mi distingue dall’altro è anche ciò che si fa unione all’altro; l’altro è come se avesse sempre fatto parte di me. Durante il pranzo di Babette è meraviglioso assistere alla graduale trasformazione della comunità che, sebbene abbia deciso unanimemente di inibire ogni forma di commento sul cibo che avrebbero mangiato, deve ammettere che l’incontro con la diversità è una esperienza unica. Per quei commensali è una sorta di ricordo nostalgico che riesce a squarciare la routine e aprire la comunità al cambiamento, ma anche al recupero di quegli affetti, di quelle relazioni che proprio la routine ha alterato. L’incontro con la diversità ha offerto una nuova alleanza, un nuovo modo di proiettare verso il futuro l’esistenza della comunità rinnovata nella relazione.
Oggi la globalizzazione ha accentuato, per via di una complessa interdipendenza dei paesi, il rapporto con la diversità che non ha solo il volto dello straniero, ma anche di culture diverse, religioni diverse, stili di vita diversi, valori diversi, ecc. . Il contatto con tutto quello che ha il sapore della novità non sempre è accolto senza ansia e senza paura; dietro l’angolo è sempre in agguato la diffidenza culturale e politica che sono sempre pronti a instillare tra la gente la possibilità che si concretizzi lo scenario angosciante del disordine sociale. Penso che il vero problema non sia solo il timore di ognuno di noi verso ciò che potenzialmente riteniamo possa destabilizzarci; forse più preoccupante è l’incapacità dei governi di vedere le grandi emergenze o i grandi temi figli della globalizzazione, ancora secondo schemi tradizionali che si ostinano a considerare erroneamente la “mappa come se fosse il territorio”, anziché superare il limite del confine geografico che è anche un limite culturale.