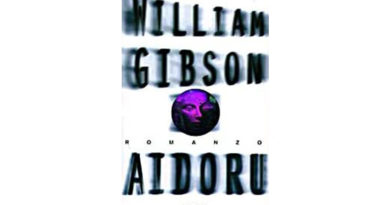Il vuoto
di Mistral
Susan Varley è una illustratrice inglese che agli inizi degli anni ottanta pubblicò un libro in cui aiutava i bambini a elaborare il lutto attraverso una storiella. Nel 2018 Il grande regalo di Tasso, questo è il titolo del libro, fu pubblicato per la prima volta anche in Italia. La storia narra di un Tasso, ormai avanti con l’età, che muore e lascia nello sconforto molti animali. All’arrivo della primavera gli animali però trovavano sempre il modo di riunirsi e di ricordare i giorni in cui Tasso era vivo e di quando a ognuno di loro aveva insegnato o donato qualcosa. Quell’incontro spontaneo risultò molto utile agli animali, in quanto riuscì a liberarli dalla malinconia e addirittura a farli sorridere quando qualcuno raccontava un aneddoto su Tasso. Insomma una di quelle storie per bambini che, pur non avendo un lieto fine, narrano la morte con la stessa naturalezza con la quale si scrive dei bei momenti. Bisogna ammettere che parlare di morte, soprattutto ai nostri giovani figli, ci irrigidisce non poco; la sola parola ci evoca presagi che non vorremmo mai occupassero i nostri pensieri nemmeno per un istante. Il filosofo Davide Sisto a riguardo afferma che «in Occidente viviamo infatti ancora all’interno di un contesto sociale e culturale che rifiuta tassativamente il pensiero della mortalità e tiene a debita distanza il corpo dei defunti. Parlare di morte, durante un pranzo tra amici o in una trasmissione televisiva, è considerato tutt’oggi inopportuno, macabro e di cattivo gusto». La pandemia di coronavirus è stata foriera di tanti cambiamenti nella nostra quotidianità e l’immagine ridondante della morte è una di quelle con cui abbiamo imparato a convivere: i morti annunciati dai bollettini periodici della protezione civile, i morti delle singole regioni, i morti nelle proprie città e poi ancora gli amici, i parenti, i semplici conoscenti, che hanno perso la loro battaglia contro il virus, e che dire della conta dei morti in questo o quello stato nel globo terrestre, o delle immagini televisive di decine di bare stipate nelle stanze, o ancora dei cortei di camion dell’esercito colmi di bare che trasportano quei poveri corpi chissà dove, o le raggelanti fosse comuni in America.
La morte viene a creare un vuoto esistenziale nelle persone ancora in vita a cui il defunto era in qualche modo legato. Forse è il vuoto il vero protagonista, ancor più della morte, di questa angosciante pandemia: il vuoto delle città, dei luoghi di aggregazione, dei negozi, delle strade, ma anche il vuoto del distanziamento sociale, quello affettivo, relazionale, quello della interruzione della nostra quotidianità, il vuoto a cui ci induce l’igiene personale per liberarci di ogni traccia di impurità, il vuoto causato dall’isolamento tra Stati o quello che provoca una richiesta non accolta di solidarietà, o ancora il vuoto dei volti inespressivi per via delle maschere, il vuoto della solitudine dei malati in terapia intensiva, quello degli anziani, quello dei senza tetto, il vuoto di Piazza San Pietro, e ancora il vuoto angosciante di un futuro incerto. Insomma un vuoto così spinto all’esasperazione che una società civile non prevedeva di dover sperimentare. D’un tratto la società frenetica a cui eravamo abituati, la società che non accettava tempi morti ma imponeva di colmarli con treni ad alta velocità, o con consegne ultra veloci, con esagerate stimolazioni visive e uditive mentre passeggiavamo, giocavamo, guidavamo, ebbene quella società ha subìto una brusca frenata. Gillo Dorfles, in un suo storico saggio, scriveva che «l’ipertrofia segnica ha raggiunto un parossismo per cui avvertiamo (o meglio dovremmo avvertire) sempre di più la necessità d’una pausa immaginifica»; quella pausa ce l’ha imposta il virus, offrendoci una tregua dall’«inquinamento immaginifico». Dorfles, quasi in maniera profetica, riteneva che la società contemporanea stesse rischiando di essere vittima di un horror pleni a tal punto da inibire l’affermarsi del between, che per il grande intellettuale implicava «la speranza e l’incoraggiamento all’uomo (alla donna) d’oggi di affermare la propria autonoma individualità, ristabilendo tra sé e il prossimo, tra la propria epoca e la successiva, tra le azioni quotidiane e le creazioni artistiche quella pausa, quel between, senza il quale l’Umanità rischia di precipitare nell’orrore d’un “pieno” non più frammentabile e domabile, e di divenire totalmente succube del “troppo pieno” e dell’eccessivo “rumore”». Il repentino distanziamento sociale a cui ha costretto la pandemia, ci ha sicuramente spiazzati, ma dopo giorni e giorni di quarantena percepiamo nel nostro intimo che quel vuoto, quel between, proponendoci di misurarci con la tolleranza nella convivenza, con il valore della famiglia, il valore della solidarietà, il valore dell’altro, ci offre una “qualità” esistenziale che si contrappone nettamente al vuoto che abbiamo spesso sperimentato nel pieno delle città, ovvero quella forma di solitudine, per dirla con le parole di Galimberti, «che non è la disperazione che attanaglia quanti un giorno hanno sperato, ma una sorta di assenza di gravità di chi si trova a muoversi nel sociale come in uno spazio in disuso, dove non è il caso di lanciare alcun messaggio, perché non c’è anima viva che lo raccolga, e dove, se si dovesse gridare ‘aiuto’, ciò che ritorna sarebbe solo l’eco del proprio grido». Il rischio per molti è che quella sensazione di «assenza di gravità» si amplifichi in questi momenti difficili e il vuoto torni a essere più insidioso di prima e risucchi a sé, come una sorta di buco nero, qualunque barlume di speranza, qualunque possibilità di erigere nell’intimità del proprio cuore progetti per il futuro. Quel vuoto, da cui dobbiamo con tutte le nostre forze fuggire, assume, sempre secondo Galimberti, la triplice forma della freddezza razionale quando si assiste all’esplosione di una «razionalità mai diluita nell’emozione», dell’ottimismo egocentrico che induce le persone a non chiedere «più nulla nemmeno a se stessi, e si dedicano totalmente al compito di inventare nuove regole del gioco laddove grava la routine», e infine dell’inerzia conformista propria della “tipologia degli abbastanza”, ovvero di coloro che non intravedono «nessun progetto per il futuro anche perché non ci sono abbastanza opportunità, nessun ideale da realizzare anche perché non ce ne sono di abbastanza coinvolgenti». Questo tipo di vuoto generato dalla pandemia è subdolo perché sa come agire sulle nostre paure le quali, alimentate oltremodo dalla noia, fanno esalare nei nostri pensieri i fumi neri e onusti della nostra vita interiore inducendo alla disperazione. Se solo fossimo consapevoli che quelle pulsioni recalcitranti sono l’immagine tutta umana dei nostri limiti, useremmo il silenzio del vuoto per riflettere su quei limiti, ritenendoli non solo limitanti ma anche parte del nostro stesso contorno, sono ciò che ci definiscono e ci rendono unici. Se solo riuscissimo a volturare quei limiti, come direbbe Robert Cheaib, «in traiettorie della nostra unicità e della nostra creatività», avremmo un’occasione in più per ripartire, finita la quarantena, liberi almeno dal contagio più aggressivo in tempi di crisi che è quello dell’accidia.