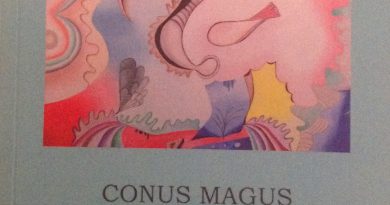Incontro con la poesia dialettale : Mara Seccia
INCONTRO CON LA POESIA DIALETTALE
Una intervista informale alla poetessa Mara Seccia
di Raffaele Simoncini
In un sonnolento e grigio pomeriggio di fine inverno, in un noto bar di “Portanuova”, in un ambiente discreto e in una atmosfera cordiale, ho avuto il piacere di incontrare la poetessa Mara Seccia e di discorrere con lei di poesia e dialetto. L’incontro era stato preparato dal dott. Gennaro Passerini, fondatore ed editorialista de Il Sorpasso, nella sua versatile e costante attività di scoperta e valorizzazione delle voci significative del patrimonio culturale abruzzese. Traggo alcuni spunti di riflessione dalla lunga e interessante chiacchierata con la poetessa, che riporto nella forma di un’intervista, funzionale alle necessità editoriali.
D. Nella poesia, così come in ogni produzione letteraria, credo sia d’obbligo muovere da alcuni dati della biografia personale…
R. La mia biografia sembra ricalcare una sorta di fotografia di una data epoca, soprattutto se inserita in un contesto così caratterizzante, come quello di una zona molto circoscritta della Pescara di qualche decennio addietro: quella che gravitava nell’area di Piazza Garibaldi e nelle numerose e storiche strade che la circondavano e la circondano, da Corso Manthonè a Viale D’Annunzio. La mia famiglia era numerosa, come molte altre, ma aveva una sua specificità: io ero l’ultima figlia della seconda moglie di mio padre, rimasto vedovo con quattro figli: dunque, come si direbbe in lingua italiana, io avevo due fratelli e quattro fratellastri. Non le sembra che sia proprio brutto ed equivoco designare una rete di affetti con un termine che sembra di per sé spregiativo?
D. Indubbiamente, è come lei fa rilevare. Al di là dei legami forti che si creano in famiglie allargate – e che lei ricorda con forte coinvolgimento emotivo – lei propone una precisa, chiara contrapposizione linguistica, tra famiglia e scuola. Ovvero?
R.Non era una eccezione: potrei dire che fosse, anzi, una regola del tempo. In famiglia si parlava abitualmente in dialetto, a scuola si parlava “obbligatoriamente” in lingua italiana. A scuola, il dialetto veniva quasi considerato una forma di grave ignoranza, un brutto modo di esprimersi. Il bello, però, era che mia nonna parlava con me e con sorelle e fratelli solo – ribadisco, solo – in dialetto e noi ci divertivamo tantissimo a sentirla ripetere quelle perle di saggezza popolare che nessuna lingua convenzionale come l’italiano può tradurre efficacemente. Per quello che mi riguardava, le confesso che avevo non pochi timori a usare il dialetto, sia per i motivi scolastici di cui le ho già detto, sia perché in certi negozi del mio quartiere, del mio mondo, si faceva sfoggio di un italiano volutamente ricercato, come segno distintivo di finezza e di “civiltà” ….
D. Mi pare di capire, però, che il dialetto fosse di comune uso, in altri e numerosi ambienti popolari del suo mondo di giovane ragazza.
R.Ma nel quartiere, per strada o nei negozietti o nei mercatini abituali, si usava solo il dialetto! Lei si immagina una ragazza che volesse usare la lingua italiana con il contadino che veniva con il suo cesto a vendere prodotti freschi dei suoi campicelli?
D. E il dialetto era un forte legame sociale e affettivo…
R.Noi ragazzi vivevamo e giocavamo per strada: la nostra vita erano quei luoghi, quelle vie, quei giochi, quelle amicizie. Tra di noi non esistevano differenze sociali: dal figlio dell’operaio e dell’artigiano a quello della borghesia benestante (tra i nostri amici vi era il figlio del “dottore” …), tutti insieme si stava a giocare con quelle invenzioni fantastiche e con tutte le variazioni originali che hanno fatto la storia di decenni di vita. Lei pensi soltanto alle guerre fatte con fucili e pistole di legno, rudimentali e però efficaci; o a nascondino; o alla “bandiera” e cosi via.
D. Si trattava, dunque, di un mondo molto vario e ricco di personaggi originali …
R.Certo, un mondo che già da ragazza mi appariva come un grande palcoscenico teatrale. Su di esso recitavano, per così dire, quelle figure che segnavano le nostre esperienze e che sono rimaste indelebili nella mente: ricordo il dr. Nando che amava le formiche e si fermava a guardarle (e, forse, parlava anche con esse), Ottavio che alla stazione aveva il suo cavallo e la sua carrozzella, in attesa di improbabili o rari clienti, Santarella che ci portava al mare e ci faceva costruire la rudimentale capanna, per ripararci dal sole. Ovviamente, questo palcoscenico richiedeva solo e soltanto l’uso “stretto” del dialetto!!
D. Poi, quando la vita ci impone le scelte da adulti, si cambiano abitudini e modi di vita. Lei mi parla della sua famiglia ma, anche, del suo amato lavoro di insegnante di scuola elementare. Ne deduco, quindi, che lei ha avuto, come destino personale, questo dilemma tra lingua convenzionale italiana e dialetto!
R.Forse, le sembrerà contraddittorio e inspiegabile, ma proprio l’attività di insegnante mi ha riconciliato con il mio grande amore per il dialetto. Con i bambini sono stata felice ed essi mi hanno insegnato tanto, ad esempio a stare bene insieme e a volerci impegnare ad insegnare-imparare tanto e con precisione e impegno costanti. Con loro ho riscoperto il dialetto, la bellezza, l’espressività della nostra “parlata”.
Solo dialetto a scuola?
R.Io e i bambini facemmo un patto: imparare perfettamente la lingua italiana, la nostra apertura umana e sociale verso gli altri, senza per questo dimenticare la lingua delle proprie tradizioni, delle proprie radici. Era la lingua delle strade, del quartiere, degli anziani, dei nonni e delle nonne: insomma, degli affetti più forti e delle memorie più care dei luoghi che li avrebbero accompagnati sempre, nella loro crescita e nella loro conquista di un’autonomia di giudizio e di scelte.
D. Un “contratto” che, ritengo, avrà avuto un suo seguito …
R.Come lei ha già compreso, quando si muovono affetti profondi e richiami alle radici delle proprie tradizioni, si muovono anche le persone. Come venne reso noto il contenuto del mio contratto con i bambini, cominciarono a venire a scuola nonni e persone anziane, per capire se i nipoti avessero riferito cose vere o meno. Quello fu il momento più significativo della mia carriera di insegnante di scuola elementare.
D. Avevo già rilevato, nella sua produzione poetica, un testo meritevole di particolare attenzione: una raccolta di poesie – corredata da un cd con testi dialettali della tradizione abruzzese, cantati da un coautore – come “messaggio” da trasferire ai bambini. Si tratta di un’idea originale: arriva alla fine di un di percorso di ricerca o è solo un inizio di una diversificazione nella sua produzione di poesia dialettale?
R.Non vorrei scadere nella banalità, ma è un progetto di sintesi e un momento iniziale, una “partenza” verso un percorso ancora da scoprire. Per una come me, che ha vissuto il “dramma” di dover quasi “vergognarsi” di usare il dialetto, poterlo oggi fare, come un progetto educativo per i bambini del nostro tempo, significa far loro scoprire un qualcosa che non hanno mai potuto conoscere, se non in modo sommario ed approssimativo. Questi bambini non hanno radici, sono figli del mondo: eppure, il dialetto si presenta e si esprime nelle loro comunicazioni. Peccato che non ne possano o sappiano intravvedere un senso di appartenenza!
D. Ma lei continua ad usare il dialetto, al di fuori dei canali ufficiali della lingua italiana?
R.Le faccio una confidenza: qualche volta, mi riunisco con bambini di cinquanta-sessanta anni, conosciuti e frequentati in quel mio mondo ristrettissimo e, ad un tempo, senza confini. La nostra gioia più esaltante è quella di ricordare fatti e momenti del nostro passato, solo ed esclusivamente parlando un dialetto stretto e impenetrabile, quasi per iniziati. Quando torno a casa, da una parte sorrido divertita, dall’altra mi commuovo profondamente. È in questi momenti che ripeto a me stessa un pensiero che, ormai, vado scrivendo spesso nei miei testi: il dialetto non è una contraffazione dell’italiano. Il dialetto è una lingua essa stessa.
E, al presente, conoscere almeno due lingue, anziché una sola, è senz’altro preferibile! Mi piacerebbe parlarle, in tal senso, anche di una festa popolare ormai dimenticata a Pescara, ma che era bella, viva e importante solo qualche tempo addietro: la festa di S. Cetteo. Viverci in mezzo, ascoltare le persone e quelle forme dialettali praticamente intraducibili in lingua italiana, era un “miracolo” che si ripeteva ogni anno e sempre in modi diversi. Molte mie poesie muovono proprio da quel mondo e da quelle lingue che si incrociavano e dai personaggi che le usavano: quasi una riproduzione della mitica e biblica torre di Babele! Spero di potergliene parlare in una prossima occasione.
Ci saranno senz’altro modi e tempi per poterlo fare. La ringrazio per la sua disponibilità, anche a nome della direzione de Il Sorpasso.