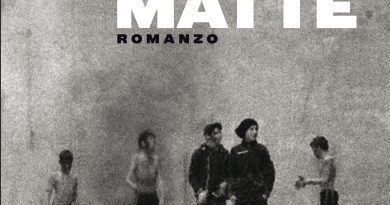Il potere è sempre un male
di Marco Tabellione
Il Maestro e Margherita è un romanzo di Michail Bulgakov, scrittore russo della prima metà del Novecento; si tratta di un romanzo dalla storia abbastanza singolare, perché non fu letto dai contemporanei, ma, pubblicato negli anni sessanta, è stato conosciuto solamente dai posteri. Se si dovesse sintetizzare questa lunghissima opera in poche parole, si dovrebbe dire che si tratta di un romanzo votato a condannare il potere tout court. Nella fattispecie si tratta del potere staliniano, con cui Bulgakov ebbe a che fare dopo che da giovane aveva militato nell’armata bianca e quindi tra i nemici dei comunisti.
Nell’opera, alquanto surreale, Satana in persona giunge a Mosca a punire le frange dell’organizzazione statale e in modo particolare gli affiliati all’associazione nazionale degli scrittori. Satana, attraverso una serie di giochi di magia alcuni dei quali apparentemente crudeli, comincia a punire molti degli scrittori dell’associazione e anche altri potenti; e in ciò non si può non leggere una critica dura di Bulgakov a tutto il sistema di potere staliniano. Il romanzo è una grande esaltazione della libertà, dell’arte e della necessità di superare qualsiasi forma di controllo o censura; alla sua base, dunque, domina la considerazione fondamentale che, appunto, il potere è sempre un male. Tant’è che nel romanzo si registra quasi un’alleanza sorprendente, per certi versi scandalosa, tra il maligno e la visione anarchica di Gesù. In tutte e due i casi, infatti, l’opposizione è contro un potere che in base ad un ordine superiore dovrebbe amministrare, gestire e controllare tutte le vite.
L’idea che il potere sia un male trova molti proseliti; ciò che occorre capire è se si tratta di un male necessario. Da sempre l’uomo discute sulla necessità di un equilibrio tra interessi individuali e collettivi, dando per scontata una contrapposizione che in realtà non ha motivo di esistere. La soluzione di questi contrasti viene proprio dalla predicazione di Gesù Cristo, la quale ha dimostrato, mediante affermazioni che hanno valore anche per laici ed atei, che sarebbe possibile impostare l’esistenza senza che ci sia per forza di cose un potere a cui sottomettersi. In effetti alla base della predicazione di Cristo c’è il monito ad ogni uomo a riconoscere nell’altro una parte di sé. Si tratta di una conquista spirituale grazie alla quale è il cristiano stesso a riconoscere nell’altro una porzione di sé, come un altro sé. E’ evidente che di fronte a uomini siffatti, così in empatia fra di loro, non ci sarebbe bisogno di utilizzare il potere per ottenere l’ordine e l’armonia sociale. Questo perché si scoprirebbe che andare contro gli altri vuol dire andare contro sé stessi. Ciò dimostra che, come al solito, la soluzione è nella coltivazione della coscienza interiore dell’individuo, proprio quella che oggi viene continuamente disattesa. Solo la maturazione di una coscienza del collettivo, cioè dell’idea che ogni individuale si realizza pienamente nell’universale, potrebbe portare a una riduzione della violenza tra gli uomini e dunque della necessità del potere. Occorrerebbe una rivoluzione dell’immagine che ognuno ha di sé. Costruire un’identità che non sia imperniata sull’io, ma che abbia come punto di riferimento non tanto il noi, una collettività che spesso non coincide con una realtà psicologica sperimentabile, ma con ciò che gli orientali chiamano il sé. Il problema è che questo stadio dell’evoluzione spirituale non è semplice da raggiungere, è ciò che i guru spirituali chiamano realizzazione, e che Jung definisce come individuazione. Si tratta di stadi spirituali ed etici che spesso sembrano appannaggio solo di pochi illuminati. Ma non è così, e a dimostrarlo è il ruolo che il linguaggio riveste non come strumento di comunicazione, bensì come dimensione dell’essere.
In effetti è grazie al linguaggio che il bambino acquisisce un’identità, la consapevolezza di sé stesso e del mondo, e in generale ciò che noi chiamiamo coscienza, tanto che vi è una coincidenza non casuale tra apprendimento del linguaggio e inizio dei ricordi. Il linguaggio è la casa dell’essere, sostiene Heidegger, intendendo dire che, se lasciamo fare al linguaggio, se accogliamo il linguaggio interiore, che è l’attuazione personale del linguaggio appreso, allora non ci dovrebbe risultare difficile l’identificazione con gli altri. Un antico saluto Maia, in lak’ech “tu sei un altro me”, ci dimostra che quella civiltà aveva già acquisito questa idea semplice e rivoluzionaria. Non si tratta di smuovere sistemi o concepire maree di leggi, occorre lavorare a livello culturale per mettere in pratica la regola fondamentale, la legge che eliminerebbe tutte le leggi o ne ridurrebbe la necessità coercitiva. Questa legge, condivisa da molte religioni, consente la scoperta interiore del carattere sacro e inviolabile dell’altro; tale rivelazione muove dalla considerazione dell’altro come proseguimento dell’io. Naturalmente si tratta di una conquista di civiltà che non può essere raggiunta una volta per tutte, ma nei limiti delle possibilità umane potrebbe rendere migliore in modo concreto le relazioni tra gli uomini. Anzi in parte è già così: chi può dire che l’armonia sociale sia più la conseguenza dell’applicazione delle leggi, piuttosto che la messa in pratica di valori che il senso comune crea spontaneamente?
Giambattista Vico, filosofo napoletano del seicento, nella sua opera La scienza nuova, oppone alla legge il senso comune, secondo lui più adatto, poiché non coercitivo, al raggiungimento di una coesione sociale. In definitiva l’unica vera garanzia che si possano fare passi in avanti nella pacificazione mondiale, per assurdo non è la cura della collettività, ma quella dell’individuo. Non si tratta di ventilare la soluzione dei problemi esteriori all’individuo, ma l’approfondimento della sua realtà interiore. Migliorare l’interiorità vorrà dire allora migliorare il mondo esteriore, ognuno conoscendo se stesso giungerà ad una più ampia comprensione degli altri. E sarà solo ciò a consentire una più spontanea armonia ed empatia fra gli uomini, non altro, non leggi, né regole né tantomeno guerre.