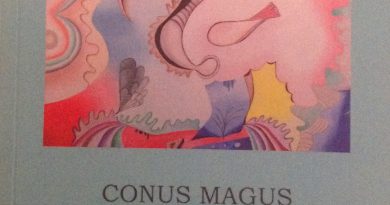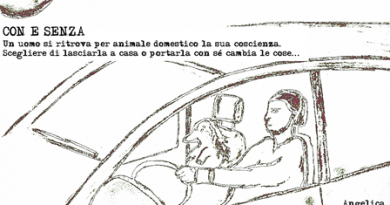Il segreto nella tomba (prima parte)
Un pallido sole feriva i vetri della biblioteca, erano giorni che scartabellavo decine e decine di libri alla ricerca di uno spiraglio per impostare la tesi di specializzazione, più che archeologo mi sentivo un topo di biblioteca. La mia ombra si allungava come le giornate, e fuori l’aria già profumava di primavera, il mio umore non era adeguato alle condizioni meteo e cominciavo a spazientirmi. Le ricerche non sortivano esito positivo, non erano conservati documenti comprovanti la demolizione, nel Seicento, della tomba con ambone che si trovava al centro della navata della chiesa di Santa Maria della Tomba a Sulmona: solo “secondo la tradizione” ma nulla di storicamente certo. Avevo anche trovato un testo con l’ipotesi di uno storico del luogo che sosteneva che la chiesa fosse stata edificata sui resti della casa natale di Ovidio. Non potevo lavorare solo su supposizioni, decisi di partire per Sulmona, patria appunto del grande Publio Ovidio Nasone, avevo bisogno di analizzare de visu le strutture architettoniche della chiesa, e cercare di risalire, se possibile, anche da un particolare apparentemente insignificante, alle origini storiche del manufatto. Mi sistemai in una pensione dignitosa, ma soprattutto adeguata alle mie finanze, come ricercatore percepivo un modesto compenso. Non persi tempo, mi diressi subito verso la chiesa, non avevo in mente nessuna strategia d’indagine, confidavo nella buona sorte, ma soprattutto nel mio “fiuto da detective” che in tante occasioni mi aveva supportato. La imponente facciata di Santa Maria della Tomba, a coronamento orizzontale, dominava piazza Plebiscito. Rimasi affascinato dalla sua rudimentale semplicità architettonica, tutta pietra viva, con portale centrale e finestrone a ruota. La facciata non aveva subìto rifacimenti, fortunatamente il tempo e i vari terremoti non avevano intaccato la sua bellezza. Il portale, ogivale e strombato, era importante, si componeva di colonne alternate a pilastri poggianti su un basamento in pietra e culminanti in capitelli sui quali poggiava l’archivolto composto da membrature minute decorate con tortiglioni e punte di diamante. Al centro dell’architrave era scolpito l’Agnello crucifero. Piacevolmente colpito dall’armonia delle forme, mi avvicinai ad osservare meglio, alla ricerca di qualche iscrizione e trovai, sulle imposte lignee del portale la data del 1441, quindi la sua costruzione doveva risalire alla fine del Trecento. Entrai, mi resi subito conto che l’interno era il risultato di molteplici interventi di restauro, proprio come avevo letto, delle primitive navate romaniche si conservavano le colonne a sezione circolare e gli archi ogivali. Provai ad immaginare, nel mezzo della navata centrale un monumentale ambone, finemente scolpito, che sovrastava una tomba. Indubbiamente in quella tomba doveva riposare un personaggio illustre di quel tempo, la centralità e la maestosità sella sepoltura non lasciavano dubbi. Ma chi? Dalla documentazione che avevo trovato la demolizione dell’ambone risaliva al 1619, mentre la tomba doveva essere coeva alla costruzione della chiesa che molto probabilmente era sorta per proteggere quella sepoltura. Un personaggio illustre di quell’epoca era indubbiamente Celestino V, la cui salma ebbe una storia travagliata, fu trafugata dalla chiesa di Ferentino e poi portata nella basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Chissà, Santa Maria della Tomba sarebbe potuta essere la sua prima sepoltura, in fondo Sulmona era vicina all’Eremo celestiniano del monte Morrone. Era una ipotesi che non dovevo sottovalutare e accantonare. Mentre ero immerso in questi pensieri, un calpestio proveniente dalla sagrestia richiamò la mia attenzione. Vidi uscire dalla porta un gruppo di uomini in saio bianco e mantella verde. Una confraternita, pensai. Mi diressi in sagrestia, e nella penombra scorsi un uomo seduto a un tavolino intento a scrivere. Aveva i capelli bianchi che spiccavano a contrasto con il verde brillante della mantella.
«Buonasera». Mi avvicinai con discrezione.
«Si accomodi, buonasera, in che cosa posso aiutarla? La stavo osservando, sembra interessato all’architettura della nostra chiesa».
«Sono archeologo ricercatore, sono qui per reperire notizie, documentazione o quant’altro per una ricostruzione storica della chiesa».
«Come avrà notato, sopra la porta della sagrestia c’è una lapide che fissa al 1619 le trasformazioni e l’ampliamento della chiesa».
«Ho visto, ma a me interessava saperne di più sulla tomba che si trovava al centro della navata, mi scusi, lei non è un sacerdote, dalla mantella direi che appartiene ad una confraternita».
«Confraternita di Santa Maria di Loreto».
«Ma Loreto è nelle Marche, non vedo il nesso».
«Nel terremoto del 1706 andarono distrutti i documenti sull’origine del sodalizio ma molto probabilmente la sua istituzione risale al tempo del breve pontificato di Celestino V, quando accadde la miracolosa traslazione della Santa Casa dalla Dalmazia».
«Continuo a non capire il collegamento con Sulmona».
«Si dice che alcune pietre della Santa Casa furono portate dai templari, per ordine del Papa, qui, nella chiesa di Santa Maria della Tomba. Nella porta dell’oratorio si legge Domus haec Societatis Virginis de Laureto condita fuit anno Domini MDLX».
«“Si dice” ma non c’è nessuna traccia di questa traslazione?».
«No. Mi scusi ma devo ultimare il verbale sull’assemblea appena conclusa. Sono molto occupato per l’organizzazione della rappresentazione della “Madonna che scappa”. Buonasera».
Non osai chiedergli notizie sull’evento che aveva appena nominato, il suo tono di voce non dava adito a repliche, salutai e mi diressi di nuovo nella navata centrale della chiesa. Si era fatto tardi, mi avviai verso l’uscita. Tenui raggi di sole, ormai prossimo al tramonto, proiettavano luci ed ombre sul pavimento, attraverso le colonnine ottagonali che sostenevano le arcatelle trilobate a sesto ribassato del rosone. Mi fermai di colpo, tornai indietro ed osservai meglio la proiezione sul pavimento, al centro era visibile la croce dei templari. La mia mente iniziò ad elaborare un’ipotesi, forse quello era il punto esatto della posizione della tomba rimossa, e il simbolo dei Templari mi faceva supporre che essa fosse la sepoltura di un cavaliere importante deceduto quando furono traslate le pietre della casa della Madonna di Loreto. Tornai nella mia stanza, iniziai una frenetica ricerca al computer con la speranza di vedere confermata la mia supposizione. Passai molte ore a leggere storie di Templari, ma nessuna che mi portasse a Sulmona. Decisi di tornare nella chiesa, era Sabato Santo, ci sarebbero state le funzioni religiose fino a mezzanotte. La confraternita lauretana, in un suggestivo corteo, illuminato da lampioni, stava lasciando la chiesa con una statua di Madonna in gramaglie. Ripensai alle parole dell’uomo “Madonna che scappa”, no, non poteva essere quella, il corteo procedeva lento e cadenzato, aveva tutta l’aria di un trasferimento più che di una fuga. Chiesi informazioni a delle persone che assistevano al corteo ed ebbi la conferma della mia supposizione, la Madonna veniva trasferita nella chiesa di San Filippo per la veglia notturna. (continua …)