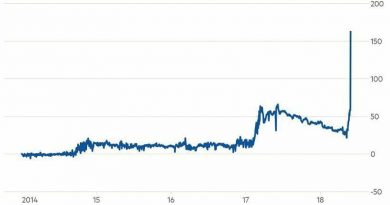I migranti e l’inclusione delle nuove generazioni
di Alessio Basilico
Ho cominciato la mia attività di insegnante nella scuola media di Rovato, in provincia di Brescia, nel 2011. Oltre alla difficoltà di trovare un modo per comunicare e interagire con gli undicenni e i tredicenni, cosa che non avevo mai fatto, le classi mi offrivano l’immagine di una variabilità etnica a me sconosciuta. Dei 22 ragazzini della prima, circa la metà erano nati da famiglie pachistane, kosovare, moldave, cinesi, senegalesi.
L’impatto del primo giorno non fu solo visivo ma soprattutto uditivo visto che tutte queste etnie imitavano in gruppo il rombo dei motori della Formula uno. Ci misi un po’ a capire come farli smettere e come guadagnare autorevolezza ai loro occhi così da poter fare lezione. Col tempo notai pure come, nonostante la maggior parte di loro avesse un fortissimo accento bresciano e nessuna difficoltà nel parlato quotidiano, alcuni problemi emergevano nello scritto e nella comprensione delle microlingue delle diverse discipline per l’interferenza delle lingue materne o perché non avevano cominciato la scuola in Italia.
Mostravano anche enormi differenze nei livelli di apprendimento. Qualcuno eccelleva, altri sembravano vivere in un altro mondo, come se la loro capacità cognitive fossero velate da una nebbia fitta e ovattata che non consentiva di vedere la lavagna o ascoltare le lezioni. Col tempo capii il perché di questa enorme differenza. Se il trasferimento delle famiglie era definitivo, i figli ricevevano un messaggio esplicito o implicito molto chiaro: studia perché l’istruzione ricevuta qui ti servirà per il tuo futuro e per trovare un lavoro dignitoso. Quando il trasferimento delle famiglie era temporaneo, i figli venivano rispediti nei paesi d’origine per tutta la durata dell’estate a stare con i nonni. Tornavano a settembre che erano meno fluenti in italiano e le difficoltà di comprensione li spingevano in uno stato catatonico di sospensione tra la propria cultura/lingua d’origine e quella che sentivano dagli insegnanti, ai loro occhi vuoti replicanti di parole che non avrebbero avuto alcuna importanza nella loro vita futura.
C’erano eccezioni a questa regola. Una studentessa cinese tredicenne leggeva due romanzi a settimana (non sto esagerando) per perfezionare la propria conoscenza dell’italiano. Odiava dover studiare gli ideogrammi del cinese mandarino e il violino, attività impostale dalla famiglia. Odiava pure tornare in Cina dove, stando alle sue parole, c’erano solo cani randagi e gente che parlava un dialetto che lei faceva difficoltà a capire. A un certo punto, nel corso dell’anno, cominciò a mandarmi i capitoli di un romanzo fantasy, scritto in italiano, perché glielo correggessi. L’anno successivo, quando io non ero più suo insegnante, continuò a mandarmi i capitoli per email. L’errore principale era ovviamente la trascrizione del suono “r”, che non esiste in cinese, e che nel romanzo poteva essere sostituito dalla “l” o usato in sovrabbondanza, come una forma di ipercorrettsimo, al posto della “l” stessa. Per il resto aveva una padronanza della lingua italiana rara per la sua età.
Nel corso di una discussione sulle discriminazioni intervenne scocciata dicendo: «Ma di cosa stiamo parlando? Questi sono esempi astratti. Le sembra giusto che io non ho la cittadinanza italiana? Questa è la vera discriminazione». Altri studenti, con una simile forte personalità, mi hanno posto successivamente la stessa domanda.
Mi si potrà dire: sono tutti aneddoti riferiti a casi isolati di preadolescenti. Il problema è ben più complesso. Può darsi… ma consentitemi un piccolo salto di spazio e tempo per riprendere poi le fila di questo discorso.
In questi giorni è morto Harold Bloom, uno dei critici letterari più noto a livello mondiale. Nei suoi lavori ha tentato, tra le altre cose, di individuare il canone della letteratura americana. Quattro sono gli autori che secondo lui primeggiano nel romanzo del secondo dopoguerra: Don DeLillo, Philip Roth, Thomas Pynchon, Cormac MacCarthy.
La famiglia di Philip Roth aveva origini ebraico-galiziane e, se non si fosse trasferita negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe stata sterminata nei campi nazisti. Don DeLillo ha origini molisane. Lo scrittore ha raccontato di aver vissuto la sua infanzia e l’adolescenza in un piccolo appartamento del Bronx parlando alternativamente italiano e inglese. La nonna dopo cinquant’anni di vita negli Stati Uniti non conosceva una parola di inglese.
Due su quattro dei più grandi maestri del romanzo americano del secondo Novecento hanno origini straniere. Il paese in cui sono nati ha investito nell’istruzione per integrarli fin dalla più tenera età. Fossero nati per sbaglio in un’altra epoca e in una famiglia che avesse deciso di emigrare in Italia, avrebbero vissuto conflitti molto più drammatici sulla propria identità, sulla lingua in cui elaborare il proprio vissuto, sui progetti per la vita adulta che coltivavano in adolescenza.
Ritorno ora a Brescia. Per inserire gli studenti italiani (così vorrebbero essere chiamati!) di origine straniera, la regione Lombardia finanziava delle cattedre di lingua italiana. Quest’ultima mi sembra una risposta concreta a una richiesta altrettanto concreta di integrazione che, in primo luogo, parte dagli stessi studenti cioè da individui in età evolutiva la cui vita cambia da un anno all’altro in maniera drammatica e che cercano di fissarsi in un’identità più o meno stabile.
Negli anni successivi ho avuto l’impressione che si passasse dal piano della realtà al piano dell’astrattezza. Infatti, rispetto alle domande dei miei allievi, le discussioni che si sono svolte sullo ius sanguinis e sullo ius soli mi sono sembrate sorrette soltanto dalle posizioni ideologiche delle forze politiche e da calcoli di breve respiro sull’immediato tornaconto elettorale. Non so perché, ma ogni volta che ho ascoltato questi dibattiti, ho pensato alla superficie lunare, dove Ariosto colloca la spedizione di Astolfo alla ricerca del senno perduto di Orlando. Rispetto alle parole della mia studentessa italiana/cinese, alla ricerca di un’identità linguistica e culuturale, quei discorsi mi sono sempre suonati fumosi e pesanti al tempo stesso. Solo che chi li faceva non doveva andare sulla luna per recuperare un tantino di concretezza. Entrare in una classe e parlare con qualche ragazzo, sarebbe stato sufficiente a tornare sulla terra e a immergersi nella vita reale.