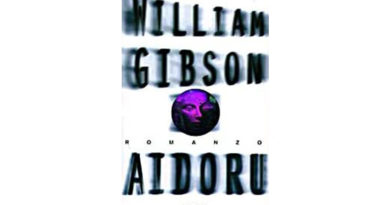Kaze no denwa (telefono del vento)
di Mistral
A gennaio di quest’anno, con un tempismo che disorienta, non molto tempo prima che la pandemia iniziasse a diventare l’argomento che avrebbe monopolizzato le nostre giornate, Laura Imai Messina ha pubblicato un romanzo dal titolo Quel che affidiamo al vento.
I personaggi della storia narrata da Laura Messina sono giapponesi ed emotivamente fragili per via di eventi luttuosi che hanno colpito le vite di persone a loro care e cercano di elaborare il lutto servendosi del Kaze no denwa, ovvero del Telefono del Vento che consente loro, parlando attraverso la cornetta di un vecchio telefono collegato al nulla, di mettersi in contatto con i propri defunti. Essendo un romanzo, la storia dei personaggi è completamente inventata, ma il Telefono del Vento è un oggetto che esiste realmente nel Nord-Est del Giappone. Del resto la stessa autrice del libro ne ha parlato in uno splendido reportage, pubblicato agli inizi di gennaio di quest’anno, sulle pagine de La Lettura.
In quella occasione Laura Messina ebbe modo di incontrare Sasaki Itaru, il guardiano del luogo in cui è custodita la cabina telefonica con all’interno il vecchio apparecchio che lui stesso ha installato. Non ci sono indicazioni stradali per arrivare al Telefono del Vento ma, come spiega l’autrice nell’articolo, «è proprio vagando, smarrendosi per questa campagna, che le persone pensano a tante cose, riformulando il ricordo di chi hanno perso. È esattamente in quella sorta di stato meditativo che arrivano al Telefono del Vento. Giungono qui in una condizione di più piena consapevolezza. Sono pronti». Quel telefono senza fili è riuscito ad attirare molte persone provenienti da ogni parte del mondo, il loro unico obiettivo è il contatto con il defunto a patto che, secondo il saggio guardiano, si sappia fare uso dell’immaginazione perché solo così, aggiunge l’autrice, sarà possibile «ricostruire una nuova relazione con le persone amate, ancora diversa da quella che avevano quando erano in vita. Un dopo non meno importante del prima».
L’essere umano ha bisogno di trovare conforto e quello strano telefono a molti riesce ad offrirlo. Il distacco prodotto dalla morte di una persona cara è sempre una ferita che difficilmente riuscirà a cicatrizzarsi completamente, ma quando la morte oltre a privarti della presenza della persona, ti priva anche del suo corpo e della cerimonia, non credo che sia possibile elaborare il lutto. L’epidemia di questi giorni ha reso il dramma della morte ancor più insopportabile perché non ha permesso a molte persone di piangere sul corpo del defunto morto di Covid-19 o avere la consolazione del rito funebre. È difficile dimenticare le immagine che hanno fatto il giro del mondo di Hart Island in cui sono stati sepolti nelle fosse comuni i morti di coloro che, sconfitti dal virus, o non avevano una famiglia o non sono stati reclamati. Ma anche in Italia la morte ha avuto la sua macabra vetrina come il brullo Campo 87 alla periferia di Milano che ospita delle semplici croci con i nomi e la data di chi ha perso la sua battaglia con il virus.
Come si possono dimenticare inoltre le centinaia di bare trasportate dall’esercito verso i forni crematori? Su questa vicenda il caporal maggiore Tomaso Chessa, rompendo il silenzio scelto dall’esercito, ha affidato a Facebook un suo sfogo scrivendo quello che ha provato in uno di questi viaggi con le bare: «… ti senti addosso una grande responsabilità, qualcosa che ti preme dentro. Ogni buca, ogni avvallamento sembra una mancanza di rispetto nei loro confronti … poi arrivi alla fine del viaggio, dove ti ritrovi ad abbandonare “il tuo carico”, che ormai fa parte di te. È come se ti togliessero una parte di cuore, ed è lì che cerchi di capire l’identità del tuo compagno … cosa difficilissima». Ma perché la morte al tempo del Coronavirus è ancor più struggente? Perché, come ricorda Guido Tonelli in un intervento sul Corriere della Sera, da sempre l’uomo ha trovato l’occasione per onorare i morti, anche nei momenti storici più drammatici la pietas verso i cadaveri è stata scandita da riti funebri di alto valore umano e religioso. La pandemia di questi giorni ha imposto una brusca sospensione di ogni forma di ritualità per accompagnare il morto nel suo ultimo viaggio, ma la sensazione è che mai come in questi giorni la morte è come se fosse prepotentemente entrata nella nostra vita.
Viene fuori, con tutta la sua forza, ciò che per noi occidentali ha sempre rappresentato la morte: un grosso problema da occultare. È un problema il dolore che prova il moribondo, è un problema il trauma emotivo dei parenti del morto, è un problema per la società consumistica fare cenno a quella fase finale della vita che toglierebbe tutto l’entusiasmo verso la spensieratezza dell’edonismo che si prova con gli acquisti. La morte nelle corsie degli ospedali è diventata un fatto meramente tecnico, si parla infatti di medicalizzazione della morte. Insomma il Covid-19, privandoci del rito funebre, anch’esso prima della pandemia vittima della modernità che lo ha svuotato della carica di drammaticità, è come se ci avesse risvegliato la coscienza anestetizzata da una società liquida che ci impone, come se fosse un obbligo morale, di essere felici. Robert Redeker, in un suo intervento su Il Foglio, non ha dubbi a riguardo e dice che «questa malattia assomiglia all’effetto della filosofia: distruggere le illusioni, la falsa coscienza. Ci costringe a tornare alla verità della condizione umana. Rompendo con l’illusione che l’uomo possa staccarsi dal dolore e dalla morte, cioè dalla vita, questa pandemia restituisce alla vita la sua drammatica sostanza».
E invece cosa ha attirato fino ad ora la nostra attenzione? È la rincorsa forsennata alla invulnerabilità quale infallibile rimedio contro il nemico più insidioso dell’uomo: la morte. Ma l’esserci concentrati in questo assurdo esercizio, ci ha paradossalmente resi più vulnerabili, in quanto incapaci di prepararci a scenari improvvisi che avrebbero potuto alterare l’omeostasi della nostra vita. Il Covid-19 è stato il protagonista insidioso di uno scenario inaspettato con cui ci siamo dovuti misurare, mettendoci di fronte a una realtà che Paolo Legrenzi, in un bel libro che esplora le nostre paure, descrive in questi termini: «L’evoluzione della nostra specie ci ha forgiato in modi che si adattano male agli scenari del mondo contemporaneo. Un mondo sempre più incerto e mutevole, che induce a concentrarsi su quelle poche cose che sappiamo fare bene per procurarci denaro e realizzare così il sogno fantastico dell’invulnerabilità e della sicurezza. Se invece di incrementare a dismisura il nostro capitale finanziario, cioè i nostri risparmi, facessimo crescere il capitale umano, studiando e imparando più cose, saremmo meglio preparati ai rovesci della sorte. A quanti più mondi possibili siamo potenzialmente adattabili, tanto meno risultiamo vulnerabili».
La pandemia è una tragedia immane per la velocità con cui il virus riesce a contagiare vite umane, per i morti che nel mondo ha causato, per il blocco delle attività economiche che ha indotto in ogni paese, per la fragilità della leadership politica mondiale di fronte a decisioni importanti, per l’impreparazione della risposta al virus dei sistemi sanitari dei paesi più sviluppati al mondo. Eppure è nei momenti in cui una tragedia mette a dura a prova l’umanità che quest’ultima riesce a far riaffiorare le sue più intime qualità che sembravano essersi dileguate per sempre. Queste qualità sono per il già citato Redeker, «la devozione, il sacrificio, tutte virtù di cui il coraggio è la radice. […] La consapevolezza della morte è la fonte dei valori, è anche la fonte della sopravvivenza della civiltà e della specie. Lo riscopriremo. Ci sarà una riumanizzazione della morte. Perché una società si perde quando la paura della morte è più forte dell’amore per la libertà».
Quando tutto questo dolore, a cui ci ha esposto la pandemia, passerà, perché passerà sicuramente, speriamo non si nebulizzi anche quel processo di umanizzazione di cui parla Redeker e allora a modo nostro alzeremo la cornetta del Kaze no denwa, consapevoli che oltre che esseri unici, siamo anche esseri plurali che non possono fare a meno di relazionarsi non solo con chi condivide con noi il presente, ma anche con tutti coloro che ci hanno preceduto e che il virus ha reso più netto il distacco da loro.